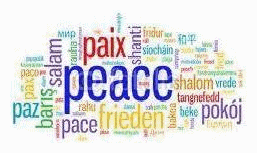Verso il Disarmo Globale: Ripensare il Potere in un Mondo Frammentato
Nel 2025 l’umanità sembra muoversi in due direzioni opposte: da una parte cresce la consapevolezza della fragilità della pace, dall’altra assistiamo a una nuova, vertiginosa corsa al riarmo. Per comprendere questo paradosso bisogna riconoscere una radice storica che attraversa gli ultimi cinque secoli: l’idea di imperialismo come prerogativa dei popoli considerati “superiori”, un paradigma nato dalla presunta centralità bianca ed europea nel mondo. Da questa forma di suprematismo culturale è derivata una struttura globale che ha giustificato colonizzazioni, sfruttamento delle risorse, imposizioni politiche e saccheggio ambientale, sempre a discapito delle popolazioni considerate “periferiche” o “inferiori”. È un’eredità che non appartiene solo al passato: continua a permeare l’ordine internazionale contemporaneo e a nutrire, in forme nuove, la spirale di conflitti che stiamo vivendo.
Le guerre in Ucraina, in Medio Oriente e negli altri teatri dimenticati non sono dunque solo il risultato di tensioni geopolitiche, ma diventano spesso il pretesto per alimentare un sistema militare-industriale che, lungi dall’aumentare la sicurezza, svuota dall’interno società già provate. La logica del potere che ha retto per secoli l’ordine globale — tra colonialismi espliciti e forme più recenti di egemonia — oggi trova nuova linfa nell’espansione delle industrie belliche. Le potenze occidentali, con gli Stati Uniti in posizione dominante, continuano a presentarsi come garanti della stabilità mentre destinano risorse crescenti alla produzione di armi, trasformando la sicurezza in un mercato e la geopolitica in uno strumento di profitto.
Il conflitto russo-ucraino mostra con evidenza questa contraddizione. Non è soltanto una guerra combattuta sul terreno: è diventato il luogo in cui si confrontano ambizioni imperiali e interessi dei complessi militari-industriali. Washington ha sostenuto la crisi trasformandola in un’occasione per riaffermare la propria centralità strategica e, al tempo stesso, per indebolire un'Europa che faticava ad affermarsi come attore geopolitico autonomo. Oggi l’Unione appare frammentata, dipendente sul piano energetico, politico e militare, e rischia perfino di essere esclusa da negoziati che la riguardano direttamente. La discussione di intese bilaterali tra USA e Russia, condotta di fatto sopra le teste dell’Europa, ripropone la logica di un mondo deciso dalle superpotenze mentre chi dovrebbe essere soggetto politico rimane spettatore.
Nel Medio Oriente, la tragedia di Gaza rappresenta uno dei punti più bassi dell’ordine internazionale contemporaneo. Gli attacchi israeliani — sostenuti da un asse politico-militare con Washington — hanno trasformato la Striscia in una zona devastata: quartieri annientati, infrastrutture civili distrutte, una popolazione stremata e intrappolata. Le dinamiche sono quelle di un massacro sistematico, riconosciuto da molti osservatori come un processo genocidario volto a disintegrare un popolo privato di cibo, acqua, cure, riparo e libertà. L’obiettivo, esplicito o implicito, di ridisegnare l’equilibrio regionale mostra come la logica del dominio sappia ancora mascherarsi dietro il linguaggio della sicurezza.
In questo scenario globale, l’Italia si muove in una condizione di crescente subordinazione strategica.
Da decenni il nostro territorio ospita basi statunitensi, centri di comando e infrastrutture integrate nella rete NATO, spesso caratterizzate da forme di extraterritorialità che sottraggono parti del paese al pieno controllo della sovranità nazionale. Da Aviano a Ghedi — dove sono presenti testate nucleari USA in ambito NATO — fino ai porti “nuclearizzati”, alle grandi stazioni radar, ai centri di intelligence e comando strategico, l’Italia è diventata uno snodo essenziale delle strategie militari occidentali. Una presenza che molti cittadini percepiscono come una vera e propria forma di protettorato militare, mantenuto nonostante la crescente opposizione delle comunità locali. È un sistema che espone il paese a rischi significativi, mentre la sua classe dirigente appare più incline ad assecondarlo che a discuterlo.
Nel frattempo, il bilancio della difesa cresce a discapito di sanità e istruzione. Le scuole faticano a mantenere strutture dignitose e personale stabile; gli ospedali pubblici soffrono carenze sempre più gravi; le liste d’attesa si allungano. Eppure il dibattito politico sembra ruotare quasi esclusivamente attorno alla necessità di “modernizzare” gli armamenti e aumentare le spese militari, trasformando in inevitabile ciò che è una scelta politica.
A questa redistribuzione anomala e dannosa delle risorse si aggiunge una tendenza culturale inquietante: la normalizzazione della guerra. Crescono iniziative che presentano l’ambito militare come spazio educativo e identitario, soprattutto per i giovani. L’idea che “la pace si garantisca con le armi” diventa il fondamento di una narrazione che trasmette alle nuove generazioni una visione del mondo centrata sulla forza e sulla sopraffazione. Così il mito della deterrenza finisce per cancellare la consapevolezza che la sicurezza nasce dalla giustizia, non dalla minaccia.
Intanto, mentre l’attenzione occidentale resta fissa sui conflitti più vicini, nel mondo ce ne sono decine che continuano nel silenzio. In Africa, Asia, America Latina si combattono guerre civili, si consumano repressioni e si consolidano regimi armati. In Africa in particolare si sta affermando una nuova stagione coloniale: Russia e Cina, attraverso mercenari, concessioni minerarie, infrastrutture opache e operazioni di influenza politica, stanno sostituendo le potenze europee in una logica che ricalca lo stesso schema di sfruttamento e dipendenza.
Il Darfur ne è una dimostrazione tragica. La popolazione non-araba è stata marginalizzata da una struttura coloniale interna che l’ha privata per anni di potere e risorse. Le atrocità commesse non derivano dal caso, ma da un intreccio di discriminazione, lotta per il controllo territoriale e interessi internazionali legati ai giacimenti petroliferi, sfruttati da compagnie statunitensi, cinesi, indonesiane e di molte altre nazionalità. È un esempio doloroso di come vecchi imperialismi e nuovi attori globali si sovrappongano nella sofferenza dei popoli.
Per interrompere questa spirale non basta denunciare l’ingiustizia. Occorre un cambio radicale di paradigma.
Il disarmo non è un’illusione: è l’unico orizzonte realistico per salvare risorse, democrazie e vite umane in un mondo che continua a prepararsi alla guerra invece che alla pace. Accanto al disarmo serve un riconoscimento pieno del diritto dei popoli all’autodeterminazione, unico antidoto ai colonialismi — passati e presenti, occidentali, russi o cinesi.
Ripensare la pace significa ripensare noi stessi. Significa scegliere la giustizia al posto della forza, la cooperazione al posto del dominio, la responsabilità reciproca al posto della minaccia. È un compito impegnativo, ma necessario se vogliamo sottrarre il nostro futuro all’industria della guerra e restituirlo alle comunità, alla dignità umana, alla cura del pianeta.
Assemblea cittadina contro la guerra ed il militarismo
6 dicembre ore 10.30
Presso il Centro Missionario in Via Mezzocannone 101